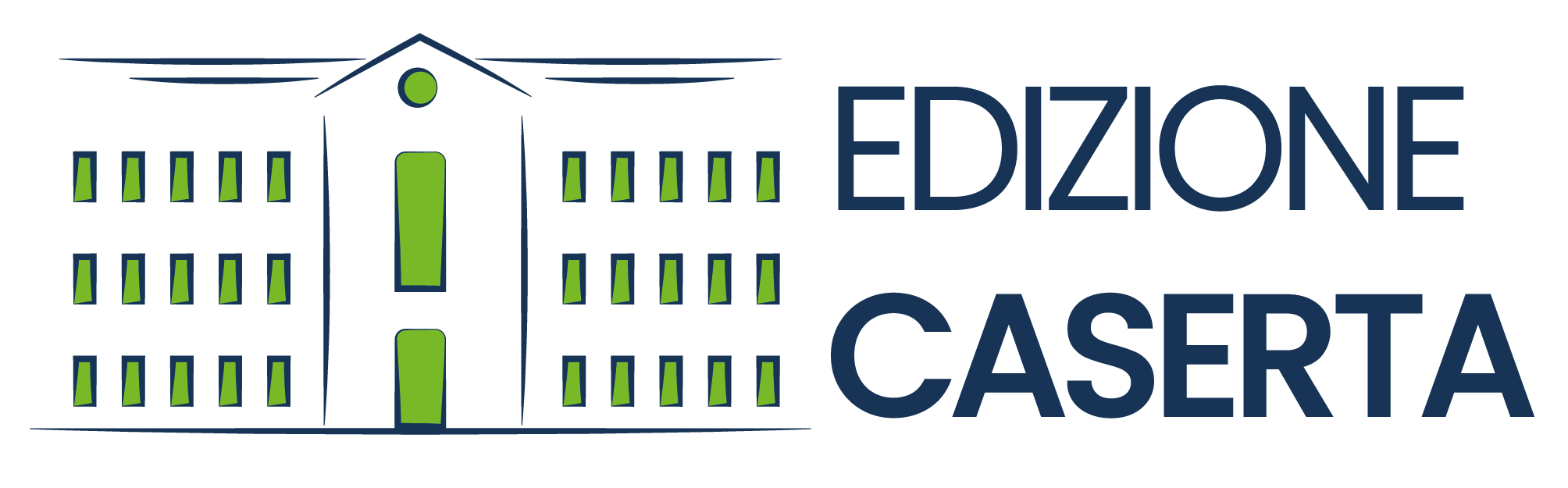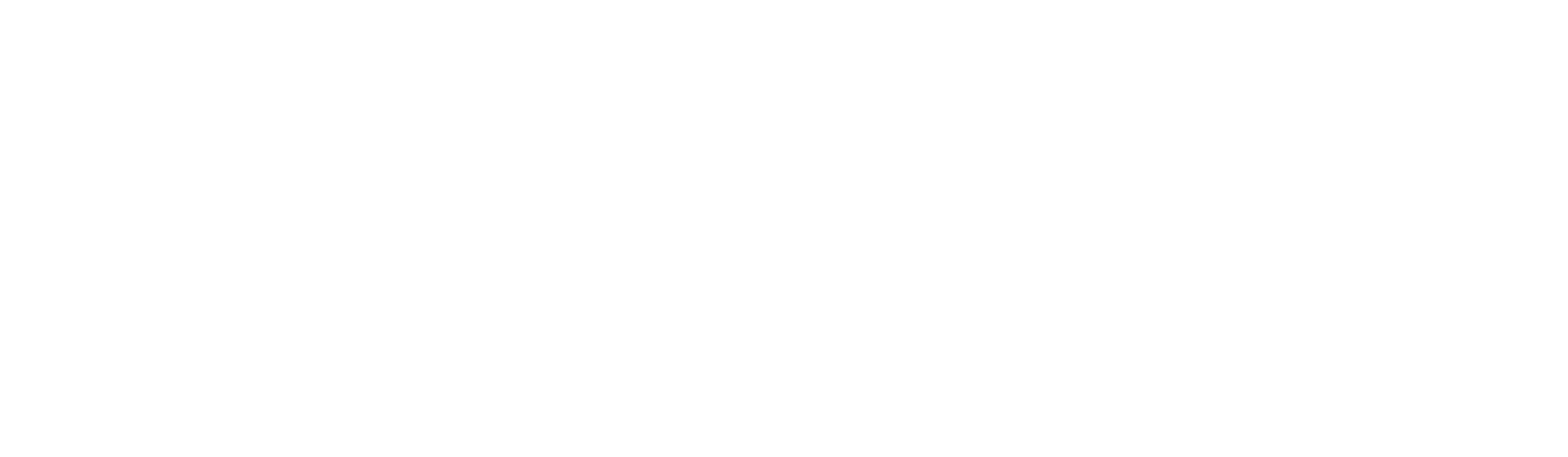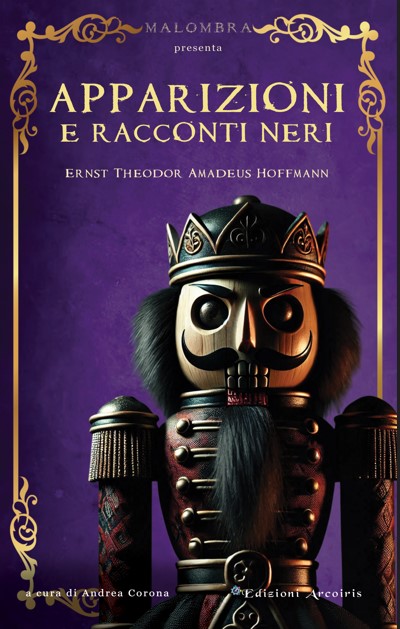
È appena uscito in libreria Apparizioni e racconti neri, primo titolo della nuova collana “Malombra”, edita da Edizioni Arcoiris di Salerno e dedicata alla riscoperta della letteratura nera e gotica. Ne parliamo con Andrea Corona, editor, consulente editoriale e curatore della collana.
Com’è nata l’idea di “Malombra” e la sua collaborazione con Edizioni Arcoiris?
Grazie innanzitutto dell’ospitalità. Il progetto nasce da uno scambio di idee con Barbara Flak Stizzoli. Nel 2023 abbiamo collaborato a un libro, “L’uomo triangolo”, una novella del dominicano Rey Andújar. In quell’occasione abbiamo capito che le nostre strade si sarebbero di nuovo incrociate e così è stato. Perché con “Malombra” la scelta è ricaduta su una collana di letteratura nera? Perché, come scrivo nella presentazione del volume, la vera conoscenza, quella che viene dalla letteratura e dalla filosofia, non ha a che fare con un tipo di sapere innocuo che agevolmente si accomoda al già noto. Al contrario: il sapere filosofico e letterario è quello che spinge nell’ignoto; ossia, spinge fuori dal noto, costringendo a vedere il pregiudizio del mondo e il pregiudizio dell’io. In ciò, il sapere letterario aggredisce e spaventa, e dunque la letteratura, per così dire, di paura, è per me una metafora per rimandare al fatto che, se la si comprende, la letteratura terrorizza.
Cosa intende dire quando afferma che la letteratura spinge fuori del mondo e fuori dell’io?
Al fondo del mondo non c’è alcun fondo mondano: il mondo è infondato. E al fondo dell’io non c’è alcun fondo egoico. Anche l’io è infondato. Come un gorgo d’acqua, illusione d’una forma con un nulla a sostanziarlo. Comunemente si crede che le paure presenti nelle storie dell’orrore (essere sbranati, soffocati, vampirizzati, sepolti vivi, o smarrirsi nella follia, come in “Malombra” di Fogazzaro) siano uno spostamento o una copertura della paura più grande, quella della morte, che sarebbe la vera paura dietro cui si celano le altre. Ma non è così che stanno le cose, per niente. Il pensiero comune della morte ha in sé qualcosa di rassicurante in quanto sposta in avanti l’oggetto temuto, al contrario di quanto fanno la filosofia e la letteratura, che costringono a dare ascolto alla pressione di una minaccia interna inconscia, portando infine alla coscienza che al fondo dell’io c’è un fondo non strutturato, e che ogni io è un nulla adesso, che ogni io è morto già adesso. La letteratura, infatti, non si occupa delle persone, bensì delle strutture: tutto è vano, scriveva Foscolo; tutto è nulla, Leopardi, che aggiungeva: un nulla io medesimo. Ecco, le paure, inclusa quella della morte, non sono altro che veli atti a malcelare il sospetto represso della nostra dissoluzione attuale. Siamo dissolvenze, e per comprenderlo occorre per l’appunto allenarsi a smettere l’io, occorre deporre la persona, che è la stupidità della coscienza, la coscienza ristretta, non la coscienza espansa, dalla perimetratura ampia, che sola consente uno sguardo sovrapersonale ossia filosofico (ed è anche ora di smetterla con il piccolo “io”, che non è argomento filosofico, né letterario).
Passando alla parte narrativa del volume, Apparizioni e racconti neri è dedicato allo scrittore tedesco del XIX secolo Ernst T. A. Hoffmann, e contiene quattro racconti brevi (Vampirismo, Una storia spaventosa, I compagni di birreria, Apparizioni, L’amante) e uno lungo, Schiaccianoci e il re dei topi. Come mai questa scelta?
Vede, il personaggio più importante del libro, quel padrino Drosselmeier costruttore del soldatino schiaccianoci, è anche un orologiaio, e non a caso è un personaggio cangiante, proprio per la sua relazione con il tempo. Viene in mente il saggio del 1931 che Samuel Beckett dedicò a Proust: il passaggio in noi del tempo ci determina come esseri di passaggio, transitori e impermanenti. Di nuovo: dissolventi. Questo racconto è un capolavoro sul tempo perché è fatto di tempo. Quando la piccola Marie si ferisce a un braccio, occorre che passi del tempo perché l’avventura possa riprendere. Ecco allora che, per tre sere, un tenebroso Drosselmeier racconta a Marie la favola della noce dura, disvelatrice di un passato immemorabile (e qui il tempo storico si fonda con il tempo mitico) che avrà da fare però i conti con la linea (narrativa e temporale) principale.
E del racconto di apertura, Vampirismo, cosa ci può dire?
Anche qui, come sopra: il vampirismo è, nella mia concezione letteraria, metafora di qualcosa di ampio. Lo scrittore David Herbert Lawrence, in un saggio su Poe tradotto in Italia nel 1966 e raccolto in un volume sui classici americani curato da Attilio Bertolucci, vedeva, nell’amore come nella conoscenza, un vampirismo della volontà e dell’intelletto: «Non è difficile capire perché ogni uomo uccide la cosa che ama: conoscere una cosa vivente vuol dire ucciderla. Bisogna ucciderla, se si vuole conoscerla bene». E concludeva: «L’avida coscienza, lo “spirito”, è un vampiro». Ebbene, una filosofia simile a quella di cui si fa portatrice la Ligeia di Poe sta anche alla base del racconto “Il segno” di Nathaniel Hawthorne, in cui uno scienziato pazzo, ossessionato da una piccola macchiolina cremisi sul volto della moglie, la sottoporrà a estenuanti esperimenti fino ad annullare infine quel segno, ma con esso la vita dell’amata. In Hoffmann, similmente, il conte Ippolito aspira a conoscere il segreto della moglie Aurelia, e non è un caso che il vampirismo si manifesterà nel racconto solo dopo le pagine in cui Ippolito ha voluto sapere e vedere. Il vampirismo, nella mia lettura, è quindi duplice.
Qualche anticipazione sulle prossime uscite della collana?
Preferisco non giocare troppo d’anticipo, ma posso certamente dire che, proprio in quanto amante delle perimetrature ampie, la collana ‘Malombra’ non sarà caratterizzata da una geolocalizzazione marcata, né sarà circoscritta al periodo gotico o preromantico. Verranno compiuti grandi salti indietro nel tempo, come pure viaggi intercontinentali.